Episodio I – La crisi strutturale e culturale dell’Occidente: una prospettiva storica
Ho recentemente ascoltato le riflessioni di Andrea Zhok, docente di Filosofia Morale all’Università di Milano, che mi hanno offerto ulteriori spunti per considerazioni che da tempo si stanno trasformando in convinzioni.
Il quadro politico internazionale attuale mostra segnali sempre più preoccupanti, che richiamano dinamiche storiche già vissute: in particolare quelle che caratterizzarono la fine del XIX secolo e che, attraverso un processo non lineare ma coerente, sfociarono nella Prima Guerra Mondiale e, dopo una pace imposta e precaria, nella Seconda.
L’idea che questi due eventi possano essere letti come fasi diverse di un unico grande conflitto, più volte interrotto e riattivato dalle contingenze storiche, non è certo nuova, ma oggi sembra assumere un’inedita attualità.
L’Occidente sembra trovarsi oggi in una condizione di impasse: una crisi profonda, al tempo stesso strutturale e culturale. Da una parte, non può mantenere la propria centralità geopolitica senza continuare ad espandersi; dall’altra, non riesce a concepire un modello alternativo a quello che ha imposto per secoli come misura universale di civiltà, sviluppo e progresso. Questa aporia, se non affrontata con lucidità, rischia di acuire tensioni già in corso e di attivare nuove dinamiche di conflitto, fino ad aprire le porte, nel peggiore dei casi, ad una nuova guerra globale diretta tra le potenze.
Alla fine dell’Ottocento, l’Occidente beneficiò del vantaggio strategico garantito dalla rivoluzione industriale: il motore a vapore, le ferrovie, il telegrafo trasformarono radicalmente la produzione, la comunicazione, la logistica militare.
In pochi decenni, l’Europa e poi il Nord America si imposero come centri globali di potere economico e politico. Ma questa espansione non fu solo tecnologica: fu anche culturale, spesso imposta con la pretesa di portare un modello di civiltà superiore, giustificando il colonialismo, la supremazia, la cancellazione o la subordinazione di interi sistemi di pensiero e organizzazione sociale.
Tuttavia, un modello fondato sull’espansione permanente non può che andare incontro, prima o poi, ai propri limiti interni: perché ogni equilibrio costruito sul movimento continuo si incrina quando questo movimento rallenta o incontra resistenze.
Oggi ci troviamo di fronte a una nuova rivoluzione: quella digitale.
L’intelligenza artificiale, la trasformazione dell’informazione in bene immateriale, la delocalizzazione produttiva e la precarizzazione del lavoro attraverso la gig economy hanno cambiato radicalmente la struttura dei sistemi economici.
Se il XIX secolo era dominato dall’acciaio e dal carbone, il XXI è governato dal silicio e dagli algoritmi. Ma anche questa nuova fase mostra crepe profonde.
La crisi finanziaria del 2007-2008 ha segnato un punto di rottura che ha scosso le fondamenta del modello occidentale: da lì in poi, è emerso con chiarezza che la tenuta di questo sistema dipende ormai da equilibri instabili e interdipendenze difficili da controllare. La delocalizzazione ha aperto spazi imprevisti per l’ascesa di nuove potenze economiche. La Cina, in particolare, ha saputo trasformarsi da “fabbrica del mondo” a protagonista geopolitico globale, sfidando apertamente l’egemonia americana.
La situazione attuale ricorda, per certi versi, quella di fine Ottocento, quando la Germania e il Giappone iniziarono a mettere in discussione la centralità di Gran Bretagna e Francia. Oggi, una dinamica simile si ripresenta sotto forma di alleanze che vanno oltre la sfera economica. Zhok propone una distinzione suggestiva tra due modelli di potere: uno talassocratico, fondato sul controllo dei mari, delle rotte commerciali, della finanza e delle tecnologie, incarnato dagli Stati Uniti e dai suoi alleati; l’altro tellurico, radicato nella continuità territoriale, nelle risorse e nei rapporti di forza più stabili, oggi rappresentato dalla cooperazione tra Russia e Cina.
Se si guarda alla mappa del blocco asiatico, si nota una fascia territoriale che va dalla Kamčatka all’Europa orientale, includendo India, Iran, e altri membri del gruppo BRICS, come l’Egitto o l’Indonesia. Si tratta di un’area che, con le nuove adesioni, rappresenta oggi oltre il 50% della popolazione mondiale: a fronte di circa un miliardo di persone che fanno capo al blocco occidentale.
Il conflitto in Ucraina ha segnato un’accelerazione decisiva: nel tentativo di isolare la Russia, l’Occidente ha favorito un consolidamento del blocco sino-russo, che si sta progressivamente strutturando in un’alternativa geopolitica credibile.
Gli Stati Uniti, nel timore di un riavvicinamento tra Europa e Russia, hanno agito per impedirlo, ma nel frattempo hanno sottovalutato l’avanzata diplomatica cinese e il rafforzamento di un polo alternativo che non solo non riconosce più la centralità dell’Occidente, ma propone un ordine differente, con regole diverse, ispirato a un pluralismo strategico e culturale.
Il vecchio paradigma occidentale, quello che garantiva stabilità e crescita interna attraverso l’espansione esterna, oggi vacilla. Le catene del valore globali sono diventate fragili, la produzione è sempre più dipendente da attori esterni, e la competitività del sistema si regge spesso su artifici finanziari e instabilità indotta.
A tutto ciò si aggiunge una crisi culturale profonda. L’Occidente ha costruito la propria identità su un’idea di universalismo -diritti umani, democrazia liberale, progresso scientifico -che ha trasformato in assiomi.
Ma questo approccio ha spesso generato una cecità strategica, rendendo difficile la comprensione, e l’accettazione, di modelli di sviluppo alternativi, che non si riconoscono nel paradigma occidentale, ma che non per questo sono meno legittimi o meno funzionali.
A questo quadro si somma un elemento cruciale, spesso ignorato ma ormai impossibile da eludere: il crescente disallineamento tra la velocità dell’innovazione tecnologica e il livello medio delle competenze cognitive diffuse nella popolazione.
Il mondo attuale segnato da volatilità, incertezza, complessità e ambiguità, quello che viene definito scenario V.U.C.A., genera un disorientamento collettivo sempre più evidente.
La difficoltà nel decifrare ciò che accade non riguarda soltanto le masse disinformate, ma colpisce in particolare le leve decisionali, ancora largamente occupate da generazioni di immigrati digitali che spesso si rivelano tenace barriera all’innovazione (sociale).
Qui, il problema si fa strutturale: il divario tra i sistemi che governano la trasformazione e i codici mentali con cui la si interpreta produce forme di analfabetismo funzionale anche ai vertici. Incapaci di leggere i segnali deboli, molti decisori pubblici e privati faticano persino a immaginare il futuro, e finiscono per reagire al presente con logiche obsolete, reiterando schemi del passato ormai inefficaci. La macchina del cambiamento accelera, ma chi ne tiene il volante guida con mappe superate.
La tecnologia evolve a una velocità esponenziale, mentre le strutture cognitive, educative ed emotive della maggioranza delle persone non riescono ad adattarsi con la stessa rapidità.
Ne deriva una forma di smarrimento culturale, che alimenta insicurezze, polarizzazioni, dipendenze e regressioni.
In molti casi, ciò che viene percepito come “crisi del sistema” è anche, e forse prima di tutto, crisi dell’interpretazione: un’erosione della capacità collettiva di dare senso al presente e al futuro.
E tutto questo è destinato ad amplificarsi. Perché se oggi l’intelligenza artificiale sta già cambiando il nostro rapporto con il sapere e la comunicazione, domani, che è già oggi, sarà la rivoluzione quantistica a stravolgere radicalmente i nostri riferimenti.
Il mondo della seconda rivoluzione quantistica ci impone un ulteriore salto concettuale: i computer quantistici non ragionano per sequenze logiche, ma per stati sovrapposti; la comunicazione quantistica non si basa su codici segreti, ma su leggi fisiche che sfuggono al controllo classico; i sensori quantistici aprono varchi percettivi inimmaginabili fino a pochi anni fa.
La realtà stessa, come la pensavamo, non regge più.
E con essa rischiano di crollare le categorie con cui l’Occidente ha costruito i suoi modelli di governance, economia, persino pensiero critico.
Il rischio, dunque, non è solo di essere impreparati tecnicamente: è di non essere pronti mentalmente.
Di trovarci con intere generazioni prive di alfabetizzazione quantistica, mentre le infrastrutture critiche, dalla sanità alla difesa, dipenderanno da processi che violano il principio stesso di causalità.
La volatilità diventa simultaneità di stati, l’incertezza si fa principio operativo, la complessità assume la forma di entanglement, l’ambiguità si radica nella struttura profonda della realtà.
Se non colmeremo in fretta questo divario cognitivo, con nuove forme di educazione, divulgazione e cultura progettuale, rischiamo di vedere la storia ripetersi in modo ancora più traumatico. Perché quando la mente non riesce più a leggere il mondo, il mondo non aspetta.
Il rifiuto del multipolarismo non è soltanto una postura ideologica: è anche un limite operativo. Genera rigidità politica, errori di valutazione, incapacità di leggere la complessità.
Quando un sistema egemonico si trova in difficoltà, la storia insegna che può reagire con strumenti di forza, nel tentativo di ristabilire il proprio primato.
Schumpeter parlava di distruzione creatrice per spiegare la logica con cui il capitalismo sopravvive rinnovandosi attraverso crisi e discontinuità.
Un tempo, le guerre servivano a rilanciare l’industria e l’occupazione.
Oggi si assiste a forme diverse di conflitto: guerre economiche, sanzioni, crisi climatiche, instabilità pandemiche, tensioni geopolitiche indotte: che diventano strumenti per mantenere attivo un sistema che altrimenti rischierebbe il collasso.
In quest’ottica, possiamo anche rileggere la Prima e la Seconda Guerra Mondiale non come eventi separati, ma come fasi di uno stesso processo storico, tenuto insieme dalla fragilità della pace e dall’impossibilità, o dalla mancanza di volontà, di accettare un riequilibrio globale.
Il trattato di Versailles non risolse le tensioni che avevano condotto alla guerra, anzi ne alimentò di nuove. E oggi, in modo simile, ci troviamo di fronte a una serie di segnali che ricordano quell’epoca: un sistema dominante che si irrigidisce, potenze emergenti che chiedono riconoscimento, e un mondo che cambia troppo rapidamente perché si possa controllare con i vecchi strumenti.
A questo punto, la domanda diventa inevitabile: cosa può fare l’Occidente per evitare di ripetere gli stessi errori?
Può scegliere se continuare a reagire attraverso il controllo e la coercizione, sanzioni, guerre ibride, propaganda, soft power, oppure può accettare la realtà del multipolarismo e ridefinire il proprio ruolo nel mondo.
L’errore più grave sarebbe quello di insistere con gli schemi del passato, incapaci di leggere il presente e pericolosi per il futuro.
Per evitare di precipitare in una nuova spirale di crisi e conflitti, sarà necessario un ripensamento profondo del modello economico, politico e culturale.
Ma soprattutto, sarà necessario abbandonare l’illusione dell’infallibilità.
Perché la storia, in realtà, non smette mai di insegnare: è l’uomo, semmai, a smettere di riconoscerla. E quando non la si vuole ricordare, la si è costretti a riviverla.
Con nomi nuovi, ma con le stesse lezioni non apprese.
Questa serie non nasce per offrire soluzioni né per distribuire colpe. Nasce per allenare uno sguardo: quello che prova a riconoscere i pattern prima che diventino destino. E nasce sotto lo sguardo del Decimo Uomo: la figura cognitiva che, quando il consenso sembra compatto e l’urgenza impone una sola direzione, si assume il compito ingrato di rallentare, dubitare, cercare l’ipotesi impopolare prima che l’inerzia diventi irreversibile.
La storia, quando ritorna, raramente lo fa con le stesse forme; cambia linguaggio, strumenti, retoriche. Ma conserva le stesse fragilità cognitive: l’illusione della necessità, l’accelerazione dell’urgenza, la rimozione del limite. Lezioni dal passato è un invito a pensare quando sembra già “troppo tardi”, a ricordare che la responsabilità non coincide sempre con l’azione più visibile. A volte, il gesto più difficile – e più umano – è fermare il meccanismo mentre è ancora possibile.
Serie in corso (in ordine):
— Lezioni dal passato – episodio 1 – Assonanze tra la fine del XIX Secolo e l’epoca contemporanea..?
— Lezioni dal passato. episodio 2: la Pedagogia del riarmo
— Episodio 3 – Lezioni dal passato. Lo schiaffo americano, l’ombra di Dugin e l’occasione italiana
— Lezioni dal passato – episodio 4. Dalla fine degli imperi alla psicopolitica della NATO
— Episodio 5 – Lezioni dal passato. Il limite rimosso
— Tredici giorni, un agosto evitato. Lezioni dal passato – episodio 6
— Libri, Armi e Codici. Lezioni dal passato – episodio 7
— Arte e scienza della cucina italiana. Lezioni dal Passato – Episodio 8
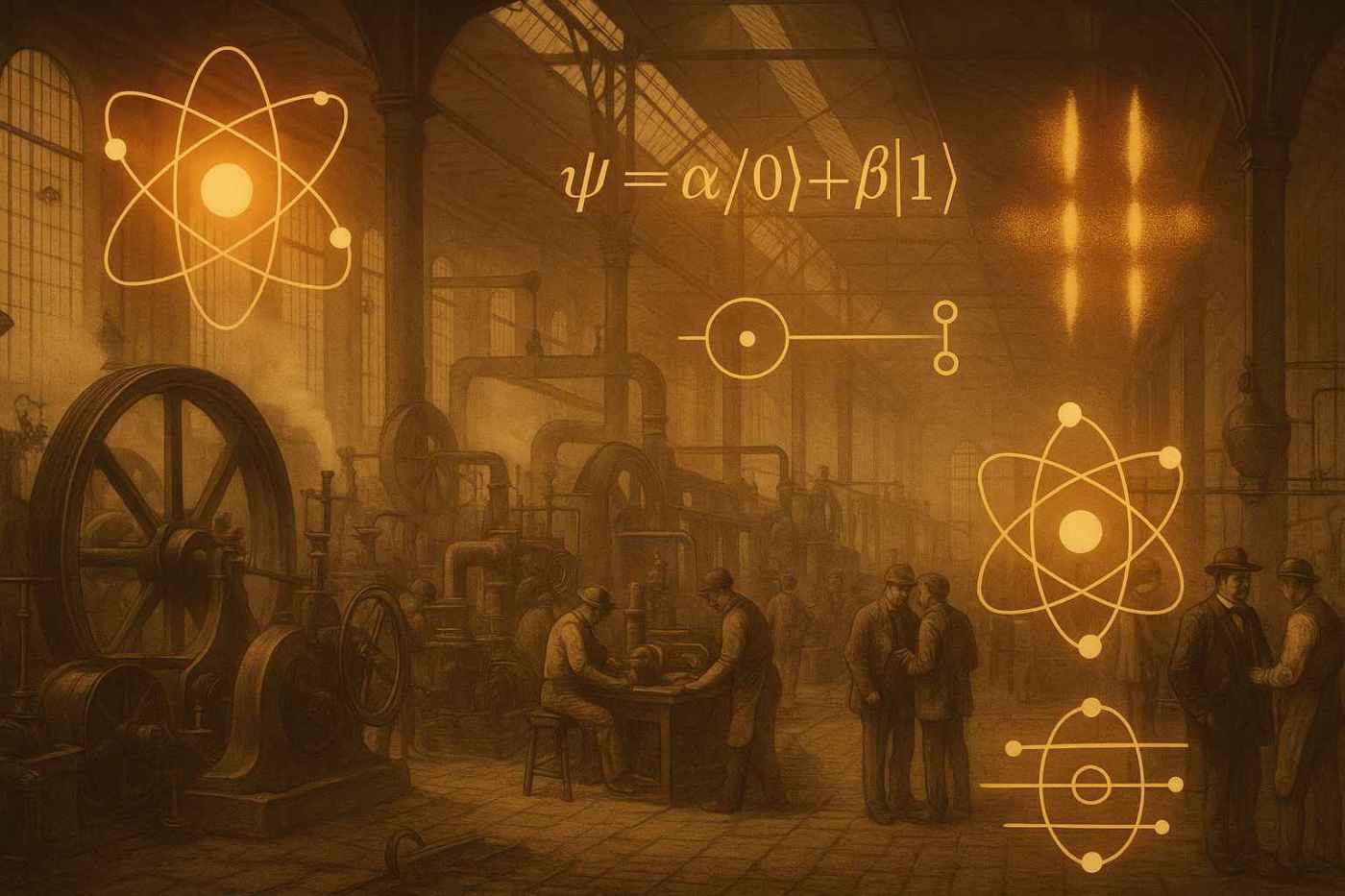
Lascia un commento