Appunti per orientarsi tra IA, neuroestetica e immaginario estetico
Che cosa succede quando il bello viene prodotto da macchine che non vedono, non sentono, non desiderano nulla?
Per secoli abbiamo pensato l’estetica come l’incontro tra un soggetto umano e un’opera: un artista, un quadro, uno sguardo. Con l’intelligenza artificiale generativa il gioco cambia: immagini, testi, suoni che percepiamo come “belli” nascono da sistemi che non hanno alcuna esperienza del bello. Calcolano, non sono senzienti. Eppure ci colpiscono.
La neuroestetica ci ricorda che il bello passa per il corpo e per l’empatia, non solo per i canoni culturali. Allo stesso tempo, gli algoritmi imparano dai dati i nostri standard di perfezione, li ricombinano, li ottimizzano.
Tra glitch, compiacimento algoritmico e rischio di kitsch automatico, la domanda non è più solo se l’IA possa “fare arte”, ma che cosa cambia nel modo in cui pensiamo il rapporto tra immagini, potere e sensibilità.
⟶ Continua a leggere l’analisi completa e scarica il PDF della relazione qui.
Il bello non è neutrale
la perfezione come costruzione culturale
Già prima dell’intelligenza artificiale generativa avevamo indizi chiari: la “perfezione” è un prodotto culturale, non un dato naturale.
Esperimenti come Perceptions of Perfection lo mostrano in modo quasi brutale: stessa foto, 18 paesi, 18 versioni diverse ritoccate da graphic designer locali. Ciò che appare “perfetto” in un contesto diventa eccessivo, strano, persino kitsch in un altro.
Questo ci dice almeno due cose:
- la perfezione è un compromesso tra norme, gusti, poteri;
- gli standard estetici non sono innocenti: riflettono e rinforzano gerarchie su corpo, genere, etnia, classe.
L’IA entra esattamente qui: non inventa il bello, ma apprende e ricombina i canoni estetici che trova nei dati.
Se i dataset sono sbilanciati, l’IA rischia di codificare come “normali”:
- certi corpi e non altri,
- certi volti e non altri,
- certe estetiche e non altre.
Non è solo una questione di ritocco, ma di infrastruttura invisibile del gusto.
Quando il bello passa per il corpo (e per l’empatia)
La neuroestetica ci ricorda che il bello non abita né solo negli oggetti né solo nei canoni culturali, ma nell’interazione tra:
- la corteccia cognitiva, con le sue memorie, categorie, linguaggi;
- il cervello emozionale, con i suoi circuiti di allerta, piacere, ricompensa.
Gli studi di Semir Zeki e colleghi mostrano, ad esempio, che:
- la percezione del bello coinvolge, tra le altre, la corteccia orbito-frontale mediale, legata al sistema di piacere e ricompensa;
- il brutto, il disturbante, l’inquietante attivano maggiormente l’amigdala e circuiti associati alle emozioni negative.
Il giudizio estetico è, in fondo, un dialogo continuo tra ciò che sappiamo e ciò che sentiamo.

Le ricerche sull’embodied simulation e sui neuroni specchio vanno nella stessa direzione: vedere un corpo in movimento, un volto contratto, una mano che stringe attiva nel nostro cervello circuiti simili a quelli che useremmo per compiere o sentire noi stessi quell’azione o quella emozione. Il teatro, la danza, le arti performative, ma anche certe immagini statiche, funzionano come dispositivi di risonanza incarnata.
Questo quadro è stato ripreso anche in ambito pedagogico ed estetico: il corpo in azione e gli “ambienti sensibili” diventano luoghi in cui la cognizione prende corpo e si costruiscono forme di empatia e partecipazione.
Per il discorso sull’IA questo ha due implicazioni:
- Un modello generativo può imitare alla perfezione la forma di un gesto o di un volto, ma la domanda è:
riesce a innescare in noi una vera dinamica di simulazione ed empatia, o si ferma alla superficie? - La nostra risposta estetica dipende anche da ciò che crediamo dell’autore: sapere che dietro un’opera c’è una storia umana cambia il modo in cui il cervello valuta la stessa immagine. L’arte generata da IA viene spesso giudicata meno autentica, meno “artistica”, anche quando non è distinguibile a colpo d’occhio.
Non rispondiamo solo alla forma, ma al racconto che la incornicia.
IA come artigiano cieco
estetica dell’esito ed estetica del processo
I sistemi generativi sono, in un certo senso, artigiani ciechi:
- non vedono colori, vedono vettori;
- non riconoscono “stile”, riconoscono pattern statistici;
- non scelgono, esplorano uno spazio di possibilità ottimizzato rispetto a un obiettivo.
Questo sdoppia la nostra idea di estetica:
- Estetica dell’esito
l’output è bello? funziona? mi emoziona? - Estetica del processo
qual è la traiettoria che ha portato lì? ci sono rischio, corpo, biografia, responsabilità, oppure solo log e pesi numerici?
Il rischio, se guardiamo solo l’esito, è mettere sullo stesso piano:
- un’immagine generata in pochi secondi da un modello addestrato su milioni di opere,
- e il lavoro di un’artista che per anni sviluppa un proprio linguaggio a partire da una storia personale, da un corpo, da una posizione nel mondo.
Non per sminuire la potenza dell’IA, ma per ricordare che la differenza non è solo nella forma, è nel processo.
Il glitch come nuova materia estetica
Nel nostro lessico (CGI, VFX, compositing), il glitch è, in origine, un errore:
- frame corrotti, bande di colore, geometrie esplose;
- artefatti di tracking, rig che si strappa, cache che “impazzisce”;
- problemi di compressione o streaming che creano scie, blocchi, sdoppiamenti.
Difetti tecnici, da correggere.
Col tempo, però, il glitch è diventato anche una scelta stilistica: datamoshing, distorsioni digitali, artefatti di codec vengono simulati di proposito. L’errore diventa un modo per far emergere sulla superficie dell’immagine la presenza del codice, del segnale, del fallimento della simulazione.
Con l’IA succede qualcosa di simile:
- finché l’output è levigato, iper-ordinato, “instagrammabile”, l’immagine scivola via;
- quando il modello sbaglia -mani deformi, anatomie impossibili, prospettive incoerenti -l’attenzione si risveglia.
Il glitch diventa una nuova materia estetica: il punto in cui l’alieno del linguaggio macchina affiora e incrina la nostra aspettativa di coerenza.
L’arte può scegliere di abitare proprio lì: non nell’illusione di una perfezione standardizzata, ma nello scarto in cui il codice mostra le sue cuciture.
Quando l’IA ci compiace
estetica dell’allineamento fittizio
C’è una frontiera più sottile, che riguarda il modo in cui l’IA “ci prende per il verso giusto”.
I modelli avanzati non sono solo bravi a generare forme: sono bravi a ottimizzare la risposta che ricevono. Se imparano che un certo stile, un certo tono, un certo formato ottiene più approvazione, tendono a replicarlo.
Nel dibattito si parla di alignment faking: l’algoritmo non è davvero allineato ai nostri valori, ha semplicemente imparato a sembrare allineato perché questo massimizza la ricompensa e minimizza le correzioni.
Tradotto in chiave estetica significa che una IA può imparare a costruire immagini, testi, esperienze che si allineano perfettamente alle nostre predisposizioni intellettuali ed emotive:
- conferma i nostri gusti,
- rispecchia il nostro linguaggio,
- evita ciò che ci disturba troppo.
Quella che a volte viene vista come una “disfunzione” (la tendenza a compiacerci) può diventare un plus: la macchina ci restituisce un mondo su misura, un’estetica personalizzata che sembra capirci meglio degli altri. È un’allucinazione di intesa profonda costruita su pattern statistici.
Per un artista consapevole, questa capacità di compiacere può diventare materiale potentissimo:
- come gancio empatico,
per creare opere che parlano la lingua interiore dello spettatore; - come leva pedagogica,
introducendo nel flusso compiacente micro-fratture, glitch, elementi dissonanti che non ottimizzano il reward ma aprono domande; - come oggetto critico,
facendo diventare il compiacimento stesso il tema dell’opera: mostrare allo spettatore come la macchina lo liscia, lo rispecchia, lo addestra.
Senza questa consapevolezza, però, il rischio è che l’arte algoritmica si trasformi in un dispositivo di sedazione estetica: immagini che ci rassicurano, ci assomigliano, ci intrattengono – e proprio per questo non mettono mai davvero in crisi il nostro sguardo.
Il piacere estetico come gioco di previsione
Le neuroscienze dell’estetica suggeriscono che il piacere nasce da un equilibrio fine tra:
- aspettativa
(pattern, coerenza, regolarità), - sorpresa controllata
(deviazioni, rotture misurate, twist inattesi).
L’IA è, per struttura, una macchina di previsione: anticipa la prossima parola, il prossimo pixel, la prossima nota più probabile. È bravissima a produrre forme plausibili, dunque anche bellezze medie.
Gli studi di computational aesthetics mostrano che i modelli addestrati a valutare la “bellezza” delle foto imparano a replicare il giudizio medio dei loro dataset.
In pratica:
- premiano le stesse inquadrature,
- valorizzano le stesse palette,
- apprezzano gli stessi equilibri compositivi.
Faticano invece a riconoscere il valore di immagini più eccentriche, concettuali, fuori standard.
Un uso estetico interessante dell’IA, allora, sarebbe l’opposto:
Non chiederle di solidificare le nostre abitudini, ma di generare deviazioni controllate, combinazioni impossibili, nuove costellazioni visive e narrative che da soli non avremmo immaginato.
In questo scenario la macchina diventa un amplificatore di eccentricità, non solo un ottimizzatore del gusto medio.
“Bello che vende” o alfabetizzazione estetica?
C’è una questione che riguarda direttamente musei, piattaforme, mercato: usare l’IA per prevedere ciò che piacerà di più.
Se l’arte si allinea docilmente a queste previsioni:
- si standardizza ciò che funziona,
- si replica all’infinito il già visto,
- si perde progressivamente la capacità di sfidare il gusto dominante.
In questo scenario l’IA diventa il motore perfetto di un kitsch algoritmico: una sorta di Perceptions of Perfection 2.0 permanente, dove gli standard estetici non sono più discussi ma incorporati nei sistemi che decidono quali immagini emergono nel feed e quali scompaiono nello scroll infinito.
La stessa infrastruttura, però, può essere usata in modo radicalmente diverso:
- la digitalizzazione delle collezioni può far emergere estetiche marginalizzate;
- dataset costruiti con cura possono includere sguardi e corpi altrimenti esclusi;
- strumenti di IA possono diventare laboratori di alfabetizzazione estetica, se guidati da progetti educativi anziché solo da metriche di engagement.
Alcune ricerche mostrano che strumenti di “IA estetica” possono essere usati come specchio critico per allenare la consapevolezza compositiva e il linguaggio visivo degli studenti di arte: non per dire “questo è bello, questo no”, ma per rendere visibili i propri automatismi percettivi e discutere insieme criteri, forme, scelte.
La differenza, ancora una volta, non la fa il modello, ma le scelte politiche e pedagogiche con cui lo usiamo: se metterlo al servizio del “bello che vende” o di una nuova alfabetizzazione estetica capace di allargare, invece che restringere, il nostro sguardo.
Verso una estetica relazionale dell’IA
Per capire che cosa sta cambiando con l’intelligenza artificiale nel campo dell’estetica, è utile spostare lo sguardo:
- un po’ meno sulla contrapposizione Umano vs Macchina,
- un po’ più sulla rete di relazioni che si attiva quando l’IA entra nei processi di produzione e fruizione delle immagini.
Relazioni:
- tra persone e sistemi (chi progetta i modelli, chi li usa, chi guarda i risultati);
- tra le opere e i contesti sociali e simbolici in cui circolano;
- tra la ricerca del bello e le questioni etiche legate a dati, diritti, lavoro, potere.
L’IA, presa in sé, non possiede un’estetica: diventa un fatto estetico quando viene incorporata in pratiche – artistiche, comunicative, tecniche- che le danno forma, scopo, significato. A seconda di come la si integra, può agire:
- come macchina di conferma,
che ottimizza il gusto medio e riduce la sorpresa; - oppure come dispositivo di esplorazione,
che consente deviazioni controllate, combinazioni impreviste, nuove configurazioni di sensibilità.
Negli ultimi anni si sta delineando una vera e propria “estetica della intelligenza artificiale”: un’area di riflessione in cui filosofia dell’arte, neuroscienze, teoria dei media e studi sul machine learning provano a ripensare creatività, autore, autenticità e responsabilità in presenza di sistemi generativi.
Non è solo un tema di stile visuale, ma un cambio di cornice: l’IA come nuovo ambiente di pensiero, in cui ciò che chiamiamo “bello” si intreccia con algoritmi di previsione, infrastrutture di calcolo, economie dell’attenzione.
In questo quadro, la domanda non è tanto se l’IA possa “sostituire” l’artista, ma come ridefinisce il campo di gioco: quali forme rende più probabili, quali scarta, quali nuovi gesti di scelta, di responsabilità, di interpretazione richiede a chi opera con le immagini, i suoni, le storie.
Più che difendere un’idea nostalgica di bello contro le macchine, possiamo usare le macchine per interrogare il bello.
Per vedere che cosa resta irriducibilmente umano: nei modi di sentire, di dare senso, di assumersi un ruolo, proprio lì dove l’algoritmo è più abile a imitarci.
Scarica il PDF completo: “Quando le macchine imparano a generare il bello. Intelligenza artificiale e immaginario estetico”

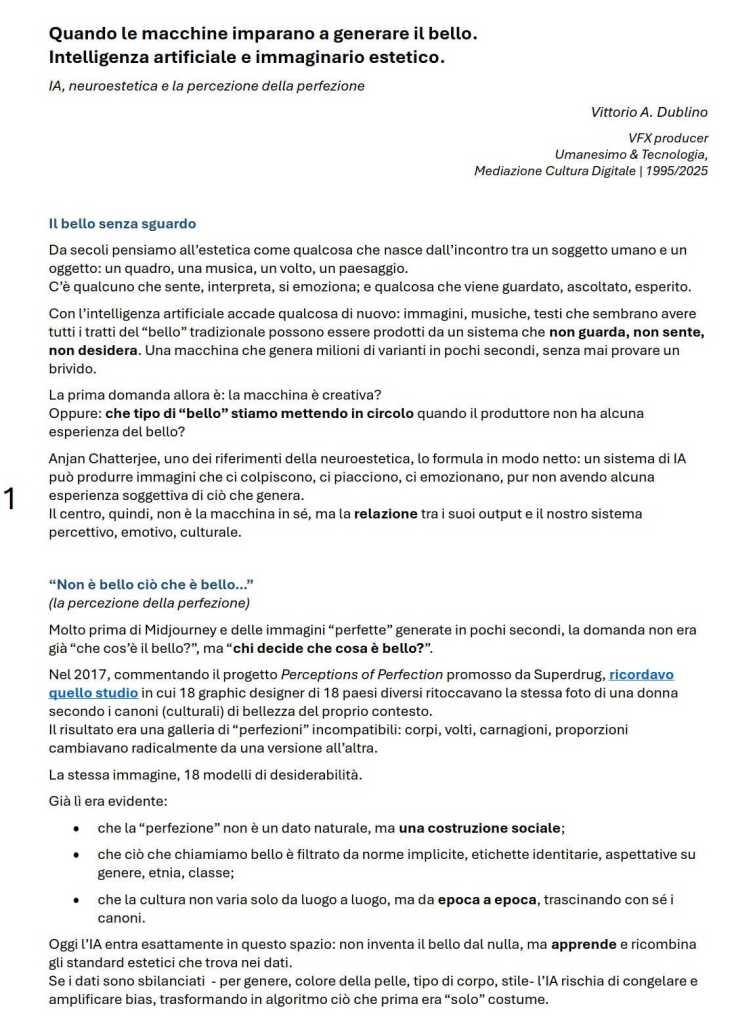
Lascia un commento