Per decenni ci siamo raccontati che l’ombrello atlantico fosse una certezza: gli Stati Uniti come Atlante che regge il cielo della “nostra” sicurezza, l’Europa come spazio da proteggere.
Il nuovo rapporto sulla sicurezza nazionale USA rovescia il frame: in filigrana, il messaggio è “non possiamo più fare tutto noi, pagate il vostro conto, fatevi i fatti vostri”. È uno schiaffo, ma anche una liberazione involontaria: incrina il vassallaggio atlantocentrico e ci obbliga a chiederci che cosa vogliamo diventare.
Nel primo episodio avevamo ascoltato Zhok: il vero punto di crisi non è “Putin” o “Xi”, ma la tenuta interna delle società occidentali, svuotate da decenni di neoliberismo che ha trasformato lo Stato in strumento operativo del mercato.
In questo vuoto di senso si infilano discorsi come quelli di Dugin: stessa critica al globalismo, ma ribaltata in mito di guerra, in “crociata” della Tradizione contro l’Occidente decadente.
È la versione ideologica del gioco a somma zero: se qualcuno si salva, qualcun altro deve essere distrutto.
È esattamente qui che si apre lo spazio italiano. Tra l’atlantismo cieco che normalizza l’economia di guerra e la fascinazione per chi promette di “spezzare il sistema” a colpi di carri armati, noi abbiamo scritto in Costituzione un’altra via: l’articolo 11, il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie. Non è moralismo: è l’unico realismo possibile per un Paese medio, esposto, nel cuore del Mediterraneo.
Se c’è una lezione dal passato che vale la pena ricordare, è che le civiltà non si misurano solo da quanto sanno combattere, ma da quanto sanno evitare le guerre che non sono sicure di poter vincere senza perdere sé stesse. È la lezione di Sun Tzu: la vittoria più alta è quella ottenuta senza combattere. Oggi la Cina la traduce in infrastrutture, commercio, finanza, soft power.
La risposta italiana non può essere la caricatura in miniatura di una grande potenza militare, ma una strategia speculare di soft power e diplomazia culturale: usare posizione, storia e capitale simbolico per disinnescare i conflitti invece che inseguirli.
⟶ Continua a leggere l’analisi completa
Lezioni dal passato – Episodio 3
Lo schiaffo americano, l’ombra di Dugin e l’occasione italiana
Per decenni ci siamo raccontati che l’ombrello atlantico fosse una certezza: gli Stati Uniti come Atlante che regge il cielo della “nostra” sicurezza, l’Europa come spazio da proteggere, educare, orientare.
Il nuovo rapporto sulla sicurezza nazionale USA rompe questa illusione.
Dietro il linguaggio felpato della burocrazia strategica, il messaggio è brutale:
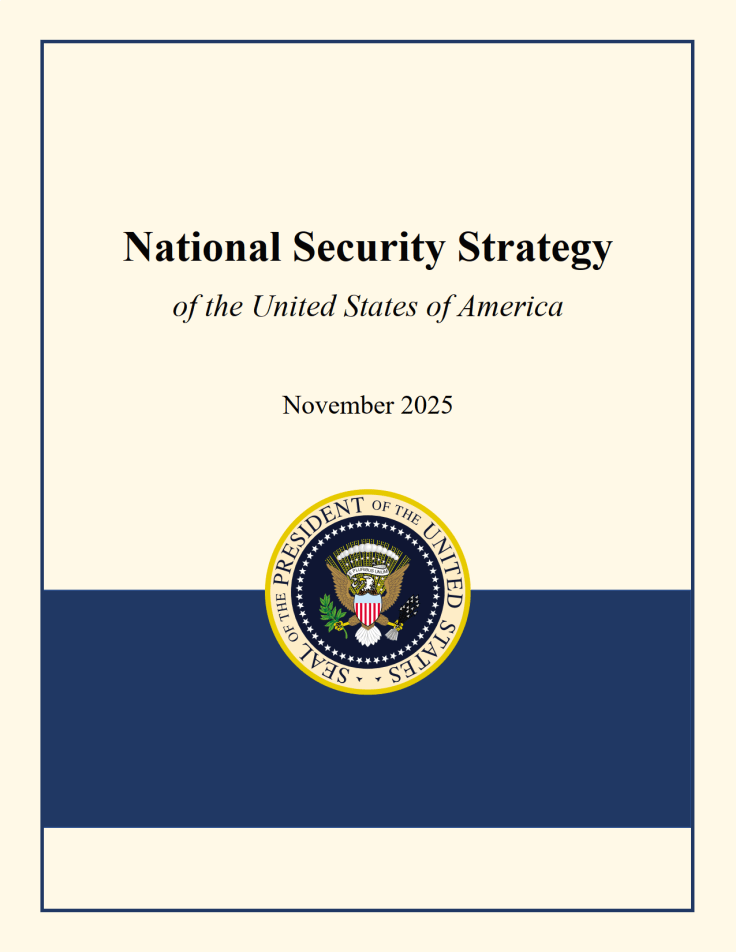
Non possiamo più fare tutto noi.
Pagate il conto della vostra sicurezza.
E fatevi, finalmente, i fatti vostri.
È, insieme, uno schiaffo e una liberazione involontaria.
Uno schiaffo a un’Europa che si crede ancora “progetto di pace” ma si scopre trattata come teatro di guerra potenziale.
Una liberazione, perché incrina il vassallaggio atlantocentrico e apre uno spazio che finora sembrava impensabile: la possibilità che l’Europa, e dentro di essa l’Italia, smetta di essere periferia docile e provi a riposizionarsi.
Per capire dove porta questo tornante, dobbiamo tenere insieme tre piani:
- la crisi interna dell’Occidente, che Zhok, docente di filosofia morale, ha analizzato con lucidità nel primo episodio di questa serie;
- la deriva ideologico-bellica che passa anche per il pensiero di Dugin, filosofo antimodernista e tradizionalista, che mette al centro spiritualità, ordine e grandezza della Russia;
- l’occasione, tutta politica, che si apre per un’Italia fedele alla propria Costituzione.
Riprendere il filo.
Dalle “lezioni del passato” allo schiaffo americano
Nei primi due episodi abbiamo guardato al Novecento:
- la corsa agli armamenti come grammatica della modernità;
- la pedagogia del riarmo, che trasforma la paura in consenso;
- la distruzione creatrice di Schumpeter letta nel ciclo guerra–crisi–ricostruzione: ogni catastrofe come occasione di nuovo accumulo.
Oggi, questo copione si ripresenta in una versione aggiornata: il riarmo torna, la retorica della minaccia esistenziale pure, ma l’Occidente non è più il centro sicuro e compatto che crede di essere.
Come ricordavamo ascoltando l’intervista di Zhok nel primo episodio, il vero punto di crisi non è “Putin” o “Xi”, ma la tenuta interna delle società occidentali:
- crisi demografica;
- frattura sociale crescente;
- concentrazione del potere economico;
- logoramento delle identità collettive e del senso di appartenenza.
Un impero non cade perché qualcuno lo abbatte dall’esterno.
Si svuota dall’interno, poi arriva la spallata.
Lo “schiaffo” americano va letto dentro questa parabola: gli USA non smettono di essere potenza, ma non reggono più da soli il peso del mondo.
Non vogliono, e forse non possono, continuare a fare Atlante.
Quando lo Stato lavora per il mercato.
La trappola neoliberale

Per capire come siamo arrivati qui, Zhok ci obbliga a fare un passo indietro sul piano delle idee.
Siamo abituati a usare “neoliberismo” come sinonimo di “meno Stato, più mercato”.
Ma la mutazione è più sottile … e più inquietante.
Il vecchio liberismo ottocentesco sognava lo Stato minimo: polizia, esercito, tribunali; il resto affidato al mercato.
Il neoliberismo nasce quando ci si accorge che questo schema non regge: lo Stato non può essere rimosso, allora viene colonizzato.
- Non è più rappresentante dell’interesse pubblico;
- diventa strumento operativo del mercato:
sanità, scuola, servizi essenziali, perfino sicurezza e beni comuni vengono trattati come pseudo-mercati: gare, appalti, indicatori, incentivi economici al posto di diritti.
Lo Stato non arretra: interviene moltissimo. Ma interviene a favore della logica di concorrenza, privatizzazione, finanziarizzazione.
Qui Zhok parla di degenerazione della ragione liberale:
- l’idea originaria di limitare il potere e tutelare alcune libertà si rovescia;
- il potere segue sempre più la proprietà, non la cittadinanza;
- la democrazia formale convive con una oligarchia economica sostanziale.
La dicotomia nascosta.
USA ed Europa
Dentro questo schema, la differenza tra Stati Uniti ed Europa è meno ovvia di quanto sembri, ed è decisiva per il nostro discorso.
Negli USA:
- l’oligarchia economica è quasi strutturalmente accettata: Wall Street, complesso militare-industriale, lobby come attori legittimi;
- la democrazia diventa sempre più cornice di legittimazione di decisioni prese altrove;
- il neoliberismo è il linguaggio naturale del sistema.
In Europa, almeno sulla carta, la storia è un’altra:
- dal Manifesto di Ventotene alle costituzioni del dopoguerra, l’Europa si definisce sociale, democratica, attenta al lavoro, ai diritti, alla coesione;
- l’Unione nasce anche per limitare la guerra, non per normalizzarla.
Eppure, dagli anni ’80 in poi, e ancor più dopo la caduta dell’URSS, anche l’Europa importa il paradigma neoliberale:
- privatizzazioni come panacea;
- “riforme strutturali” intese quasi sempre come tagli allo Stato sociale;
- competitività come mantra identitario.
Ne esce uno spazio politico schizofrenico:
- valori sociali e democratici proclamati nei trattati;
- pratiche di governo che assomigliano sempre di più a quelle di un’altra oligarchia economica in ritardo.
Lo “schiaffo” americano arriva qui.
Un’impostazione strategica che, in filigrana, dice all’Europa:
“Noi non possiamo più tenervi in piedi.
Se volete sopravvivere come blocco, prendetevi in carico la vostra sicurezza, i vostri confini, le vostre scelte.
Ma fatelo dentro questo stesso paradigma, con più spesa militare e più logica di blocco.”
Ecco la trappola: aver finito, nei fatti, per copiare il modello del vincitore americano senza pensare che anche quel modello, 30 anni dopo quello del comunismo sovietico, sarebbe potuto entrare in crisi.
Multipolarismo.
Occasione o pretesto di nuove crociate?
Piaccia o no, il mondo si sta facendo multipolare:
- non esiste più un unico centro indiscusso;
- la deterrenza nucleare rende suicida ogni progetto di annientamento definitivo del nemico;
- la convivenza tra potenze diventa necessità, prima che scelta morale.
Qui si apre una biforcazione:
- si può leggere il multipolarismo come occasione per limitare gli abusi, ridurre le pretese di dominio totale, aprire spazi di cooperazione;
- oppure lo si può trasformare in un pretesto per una nuova guerra di civiltà, con blocchi contrapposti che sacralizzano il conflitto.
È in questo secondo percorso che rientra il pensiero di Alexander Dugin.
Quando la critica al globalismo si fa mito di guerra.
Il Dugin pensiero.
Il testo di Dugin che circola da anni è un concentrato di questa deriva.
Anche lui critica:
- globalismo unipolare;
- élite tecnocratiche e finanziarie;
- decadenza dell’Occidente.
Ma da qui non trae una richiesta di più democrazia, più giustizia sociale, più redistribuzione del potere.
Trae una narrazione sacrale del conflitto:
- la guerra in Ucraina non sarebbe invasione, ma “confronto con il globalismo integrale”;
- la Russia è descritta come avanguardia della Tradizione contro il “cimitero tossico” dell’Occidente moderno;
- l’Europa viene invitata a “rompere con l’Occidente” per unirsi allo spazio eurasiatico guidato da Mosca;
- gli ucraini sono fratelli “ingannati” che un giorno combatteranno “dalla parte giusta”.
Stesse parole chiave – multipolarità, tradizione, rifiuto del globalismo – ma piegate a una logica esattamente opposta a quella di Zhok.
Dove Zhok usa la critica al neoliberismo per chiedere più democrazia, più controllo sul potere economico, più tutela del fattore umano, Dugin la trasforma in una sorta di teologia politica del conflitto:
- invece di limitare il potere, lo sacralizza;
- invece di disinnescare il conflitto, lo assume come destino;
- invece di difendere il fattore umano, lo arruola in una mobilitazione identitaria.
Per il dibattito europeo, Dugin non è un maestro da seguire, ma un campanello d’allarme: mostra quanto sia facile che la critica al globalismo, se non è radicata in principi democratici e costituzionali, degeneri in mito di guerra, soprattutto quando le società sono stanche, disorientate, impoverite.
È esattamente il bordo del baratro su cui oggi camminano molti europei: tra paura, risentimento, voglia di “ordine” e fascinazione per chi promette di “spezzare” il sistema con un colpo secco.
Italia tra il richiamo alla guerra e l’articolo 11
In questo scenario, dove si colloca l’Italia?
Finora, in modo abbastanza passivo:
- atlantismo quasi riflesso;
- faticosa fedeltà a un’Europa che parla di pace ma si attrezza per l’economia di guerra;
- sé stessi pensati più come campo di battaglia potenziale che come soggetto politico.
Eppure l’Italia ha qualcosa che né Washington né Mosca hanno: l’articolo 11 della Costituzione:
“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli
e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.
Se lo trattiamo come formula rituale, resta una frase da cerimonia.
Se lo prendiamo sul serio, diventa una possibile linea di riposizionamento strategico:
- non uscire dall’Occidente,
- non cadere nella fascinazione di Dugin o di altre crociate “anti-globaliste” in salsa autoritaria,
- ma costruire un’identità internazionale fondata su tre pilastri:
- Appartenenza critica al campo occidentale
– senza illusioni su un’impossibile neutralità, ma rifiutando l’allineamento cieco. - Rifiuto della guerra come strumento ordinario di politica estera
– non pacifismo ingenuo, ma coscienza dei limiti di un Paese medio, esposto, densamente popolato, inserito in un Mediterraneo instabile. - Vocazione alla mediazione diplomatica
– usare la nostra posizione geografica, storica, culturale (Mediterraneo, Vaticano, legami con Africa e Medio Oriente): per essere piattaforma di dialogo, non avamposto di scontro.
Dal campo di battaglia al ponte.
Cosa significa, in pratica ?
Tradotto nel dibattito politico, le possibili alternative italiane diventano più chiare.
Scenario A – Italia entra nel campo di battaglia
- più NATO come automatismo,
- aumento di spesa militare pensato solo in funzione di logiche di blocco,
- adesione acritica a ogni escalation decisa altrove,
- sacrifici sociali giustificati dall’“economia di guerra”,
- Mediterraneo vissuto solo come frontiera da militarizzare.
Scenario B – Italia diventa ponte di mediazione
- alleata degli USA ma non subordinata ai loro interessi in ogni dossier;
- promotrice, in Europa, di una lettura non bellica del multipolarismo:
competizione dove necessario, cooperazione dove possibile; - iniziative diplomatiche sistematiche su Ucraina, Mediterraneo allargato, Africa, Medio Oriente;
- uso della propria storia e della propria posizione come risorsa geopolitica e non solo come sfondo turistico.
In questo secondo scenario, l’articolo 11 non è un vezzo moralistico: è il punto di contatto tra realismo strategico e memoria storica di un continente che, due volte, si è autodistrutto in guerre “necessarie”.
Lezione dal passato III.
Lo schiaffo come esame di maturità
Il titolo di questa serie, Lezioni dal passato, non è nostalgia.
È un avvertimento.
Il Novecento ci ha già insegnato che:
- le guerre “per conto terzi” si pagano a casa propria,
- la delega totale della sicurezza produce dipendenza, non pace,
- la tragedia arriva sempre quando la guerra smette di apparire impensabile e diventa “normale”.
Oggi, lo “schiaffo” americano può essere interpretato in due modi:
- come umiliazione da compensare con un surplus di fedeltà atlantica e di retorica bellica;
- oppure come esame di maturità per l’Europa e, dentro di essa, per l’Italia.
La domanda che il passato ci rimette davanti è semplice, ma brutale: vogliamo continuare a vivere da periferia di un impero in crisi, oscillando tra l’atlantismo cieco e la fascinazione per i profeti della guerra “tradizionale”?
Oppure vogliamo provare a fare ciò che la Costituzione ci chiedeva fin dall’inizio: rifiutare la guerra come strumento di soluzione delle controversie
e usare ogni spiraglio, compreso questo schiaffo, per diventare, finalmente, un Paese che difende la diplomazia quando tutti gli altri stanno addestrando le armi?
Se c’è una lezione dal passato che vale la pena ricordare, è che le civiltà non si misurano solo da quanto sanno combattere, ma da quanto sanno evitare i conflitti che non sono sicure di poter vincere senza perdere sé stesse.
È, in fondo, una delle intuizioni centrali di Sun Tzu: la vittoria più alta è quella ottenuta senza dover combattere.
Quello che oggi leggiamo come “azione cinese” – spostare gli equilibri globali attraverso infrastrutture, commercio, finanza, soft power – è proprio una traduzione contemporanea di questa logica. La risposta italiana non può essere la caricatura in miniatura di una grande potenza militare, ma una strategia speculare di Soft Power (benevolo) e Diplomazia Culturale: usare la nostra posizione, la nostra storia e il nostro capitale simbolico per disinnescare i conflitti invece che inseguirli.
Questa serie non nasce per offrire soluzioni né per distribuire colpe. Nasce per allenare uno sguardo: quello che prova a riconoscere i pattern prima che diventino destino. E nasce sotto lo sguardo del Decimo Uomo: la figura cognitiva che, quando il consenso sembra compatto e l’urgenza impone una sola direzione, si assume il compito ingrato di rallentare, dubitare, cercare l’ipotesi impopolare prima che l’inerzia diventi irreversibile. La storia, quando ritorna, raramente lo fa con le stesse forme; cambia linguaggio, strumenti, retoriche. Ma conserva le stesse fragilità cognitive: l’illusione della necessità, l’accelerazione dell’urgenza, la rimozione del limite. Lezioni dal passato è un invito a pensare quando sembra già “troppo tardi”, a ricordare che la responsabilità non coincide sempre con l’azione più visibile. A volte, il gesto più difficile – e più umano – è fermare il meccanismo mentre è ancora possibile.
Serie in corso (in ordine):
- — Lezioni dal passato – episodio 1 – Assonanze tra la fine del XIX Secolo e l’epoca contemporanea..?
- — Lezioni dal passato. episodio 2: la Pedagogia del riarmo
- — Episodio 3 – Lezioni dal passato. Lo schiaffo americano, l’ombra di Dugin e l’occasione italiana
- — Lezioni dal passato – episodio 4. Dalla fine degli imperi alla psicopolitica della NATO
- — Episodio 5 – Lezioni dal passato. Il limite rimosso
- — Tredici giorni, un agosto evitato. Lezioni dal passato – episodio 6
- — Libri, Armi e Codici. Lezioni dal passato – episodio 7
- — Arte e scienza della cucina italiana. Lezioni dal Passato – Episodio 8
Di questa “arte della guerra senza guerra” avevo iniziato a scrivere qui: Sun Tzu e l’arte del Soft Power (parte 3) → https://vittoriodublinoblog.org/2019/11/29/sun-tzu-e-larte-del-soft-power-parte-3/

Lascia un commento