Dis-Infowar. Quando l’informazione non educa più, ma decide cosa non si chiede
Ci sono stagioni in cui l’informazione non si limita a mentire.
Fa qualcosa di più sottile e più efficace.
Non ti dice cosa pensare.
Ti fa capire quali domande non è più opportuno fare.
Non è più solo propaganda.
È una forma di addestramento silenzioso:
non all’adesione, ma all’evitamento.
La tavola rotonda di “a/simmetrie” sul tema Infowar ha messo a fuoco proprio questo passaggio:
dal conflitto tra versioni al ridisegno del perimetro del dicibile.
Non è più centrale ciò che viene detto, ma ciò che smette di essere pronunciabile senza conseguenze.
Il giornalismo, in questo clima, non viene solo orientato.
Viene indotto a non complicare.
Il dubbio, che dovrebbe essere metodo, diventa sospetto.
La complessità, che dovrebbe essere spiegata, diventa disturbo.
Non serve vietare.
Basta smettere di chiamare chi fa ancora domande.
È qui che l’informazione smette di educare e comincia a selezionare il pensabile.
Ed è qui che il problema smette di riguardare i media, e comincia a riguardare tutti noi.
⟶ Continua a leggere, alla fine troverai il rimando alla tavola rotonda
Oggi, durante la puntata di in Mezz’ora (RAI3), Monica Maggioni e Gian Micalessin – durante un servizio sul rilascio in corso dei prigionieri del sedicente stato islamico dalle carceri controllate dai curdi, sotto pressione e attacco del nuovo assetto siriano – si sono fermati su una cosa che, in tempi normali, sarebbe banale e invece oggi suona come un allarme: fino a quel momento nessun altro organo d’informazione aveva citato quella notizia.
Non stavano dicendo “noi siamo i migliori”.
Stavano dicendo: com’è possibile che una cosa così, potenzialmente esplosiva, non sia entrata nel circuito mediatico?
Ecco: il punto non è solo la notizia in sé. Il punto è il meccanismo che rivela.
Perché sempre più spesso l’informazione non si misura solo su ciò che pubblica, ma su ciò che non entra mai nel racconto comune.
Non viene smentito. Non viene discusso. Non viene nemmeno attaccato.
Semplicemente non passa.
Ed è qui che l’Infowar smette di essere il regno delle fake news e diventa qualcosa di più sofisticato: la gestione del dicibile. La costruzione del “normale”. La selezione preventiva delle domande che vale la pena fare.
Ed ecco che mi riviene in mente una tavola rotonda di a/simmetrie. Che non appare più come un dibattito tra addetti ai lavori. Appare come una diagnosi: non ci viene chiesto di capire. Ci viene chiesto di schierarci. E, prima ancora, ci viene insegnato cosa è meglio non nominare.
“dis-Infowar, il titolo di questa tavola rotonda sembra criptico.
Ma la scena è chiara. Qui non si parla solo di bugie. Si parla di clima delle asimmetrie
Il moderatore lo fa notare con una mossa quasi filologica.
Il prefisso “dis-”. Separare. Disperdere. Ribaltare. Ed è esattamente quello che succede quando informazione e guerra si sovrappongono.
Separare
la realtà divisa in campi morali.
Disperdere
la comprensione ridotta in frammenti emotivi.
Ribaltare
il giornalismo spostato da ricerca a conferma.
Orwell torna utile non per nostalgia. Per igiene. In guerra la menzogna è strutturale.
Ma oggi non è solo menzogna. È selezione. È pressione. È silenzio organizzato.
E soprattutto: è ciò che diventa impronunciabile.
Foa, su questo, è brutale: non siamo migliorati. Siamo peggiorati. Non perché prima i media fossero puri.
Perché prima c’era almeno l’illusione che la categoria prendesse coscienza delle tecniche di manipolazione.
Oggi quella coscienza non solo manca: spesso è stata sostituita da adattamento.
Meno coraggio.
Meno libertà percepita.
Meno risorse.
Più paura di “rompere le scatole”. Ma il punto vero, per Foa, non è economico. È culturale.
L’oltranzismo ideologico.
Il dibattito non dura cinque minuti: scatta subito l’etichetta.
Complottista. Filo-russo. Filo-Hamas. No-vax. Retrogrado. Fascista.
Cambia il bersaglio. Resta la pistola.
Il dubbio, che dovrebbe essere l’ABC del giornalismo, diventa un indizio di colpa.
E quando il dubbio diventa colpa, l’informazione smette di essere controllo.
Diventa propaganda.
Gaiani entra da un punto che molti percepiscono e pochi ammettono: il moralismo.
Non il giudizio morale. Quello ci sta.
La sua anticamera.
La necessità di consegnarti subito buoni e cattivi, prima ancora dei fatti. È comodo.
È rassicurante.
È tossico.
Perché trasforma la complessità in sabotaggio.
E quando la complessità diventa sabotaggio, ogni dettaglio dissonante va ripulito. Va reso “narrabile”.
L’aneddoto sul battaglione Azov “addomesticato” con parole: runico, colto, violinista, funziona proprio così: fa ridere e fa paura. Non è solo cattivo giornalismo. È sdoganamento.
Gaiani fa poi la distinzione che vale tutto il panel.
Informare è difficile, ma riconoscibile.
Propagandare è ancora più difficile: significa orientare percezioni, sincronizzare linguaggi, costruire consenso.
E il segnale sta spesso nel copione: formule identiche, ripetute ovunque.
Quando il lessico ufficiale diventa il lessico di tutti, non stai leggendo giornali.
Stai leggendo un sistema.
Poi arriva Inaro. E qui il discorso cambia temperatura.
Perché non è più teoria. È prezzo. La sua traiettoria è semplice e inquietante.
Anni ’90: la RAI come un’altra epoca. L’estero come “riserva” dove si poteva ancora raccontare il mondo.
Poi, lentamente, l’attrito. L’incompatibilità.
Pandemia da Mosca: racconta ciò che vede. Misure diverse. Strategie diverse. Vita quotidiana diversa.
Non propaganda. Cronaca.
Basta. Diventa stonato. Le chiamate calano. La voce evapora.
Ucraina: prova a fare una cosa elementare. Mostrare una cartina. Dire che esiste anche un punto di vista dall’altra parte. Raccontare cosa dicono Putin e Lavrov senza “aderire”.
Progressiva estromissione.
Cairo: con Gaza la scena si ripete. Raccontare come la pensa il mondo arabo diventa un atto non richiesto. Quindi un atto punibile.
La frase che resta è questa: la forma peggiore di controllo non è la censura esplicita. È l’autocensura.
Non ti vietano di parlare.
Smettono di chiederti di farlo.
E tu impari a non complicare. A non spostare l’asse. A non fare la domanda sbagliata.
Il costo non è solo personale. È cognitivo. Perdiamo categorie e strumenti.
E quando l’informazione rinuncia a spiegare la complessità, la realtà non sparisce.
Arriva lo stesso. Solo che arriva senza mediazione.
Eppure, in fondo, nel panel c’è una crepa di luce, è la “terra di mezzo”. Tra mainstream e alternative.
Uno spazio enorme di persone che non cercano certezze assolute, ma strumenti per orientarsi.
Parole non militanti. Dubbio non criminalizzato. Complessità non ridotta a slogan.
Però quella terra di mezzo, se vuole contare, ha bisogno di due cose difficili.
Indipendenza reale e sostenibilità economica.
Qui metto un dato come indicatore, non come medaglia: questo blog ha superato le 200.000 visualizzazioni. Non dice “abbiamo ragione”.
Dice che esiste domanda di metodo.
Domanda di contesto.
Domanda di comprensione.
C’è poi un equivoco che in tempo di guerra diventa velenoso: la parola “sicurezza” usata come cappello universale. Un Paese serio può avere perimetri legittimi: non pubblicare ciò che mette a rischio operazioni, persone, capacità.
Il segreto esiste. Non è scandaloso.
Il problema nasce quando il segreto smette di essere perimetro e diventa riflesso.
Non dire. Non intervistare. Non ascoltare “la parte avversa”.
Non perché ci sia un rischio operativo.
Perché la complessità disturba l’allineamento.
Su questa distinzione avevo scritto anche altrove, come ad esempio in I Media e i Segreti, per la sicurezza nazionale.
Se il perimetro non è riconoscibile e motivato, non è sicurezza. È disciplina.
E la disciplina, quando diventa costume, produce autocensura senza bisogno di decreti.
È qui che il mio “Decimo Uomo” torna utile. Non come protagonista. Come freno d’emergenza.
Non è quello che “ha ragione contro tutti”. È quello che potrebbe impedire a qualcuno di scambiare l’allineamento per verità.
Fa una cosa sola: rallenta lo schieramento.
Chiede: cosa manca? Qual è il frame?
Quale domanda è diventata impronunciabile?
Non per simpatia verso il nemico.
Per fedeltà a una facoltà fragile: decidere senza essere ipnotizzati.
Perché il punto finale è questo: quando l’informazione smette di spiegare e comincia a schierare, produce cittadini militanti ma non informati.
E una democrazia di cittadini militanti ma non informati è una democrazia suggestionabile.
Il diritto di complicare non è un lusso.
È una forma minima di sicurezza collettiva.
E io, nel mio piccolo, continuo a fare una cosa sola: cerco di capire insieme dove va il mondo.
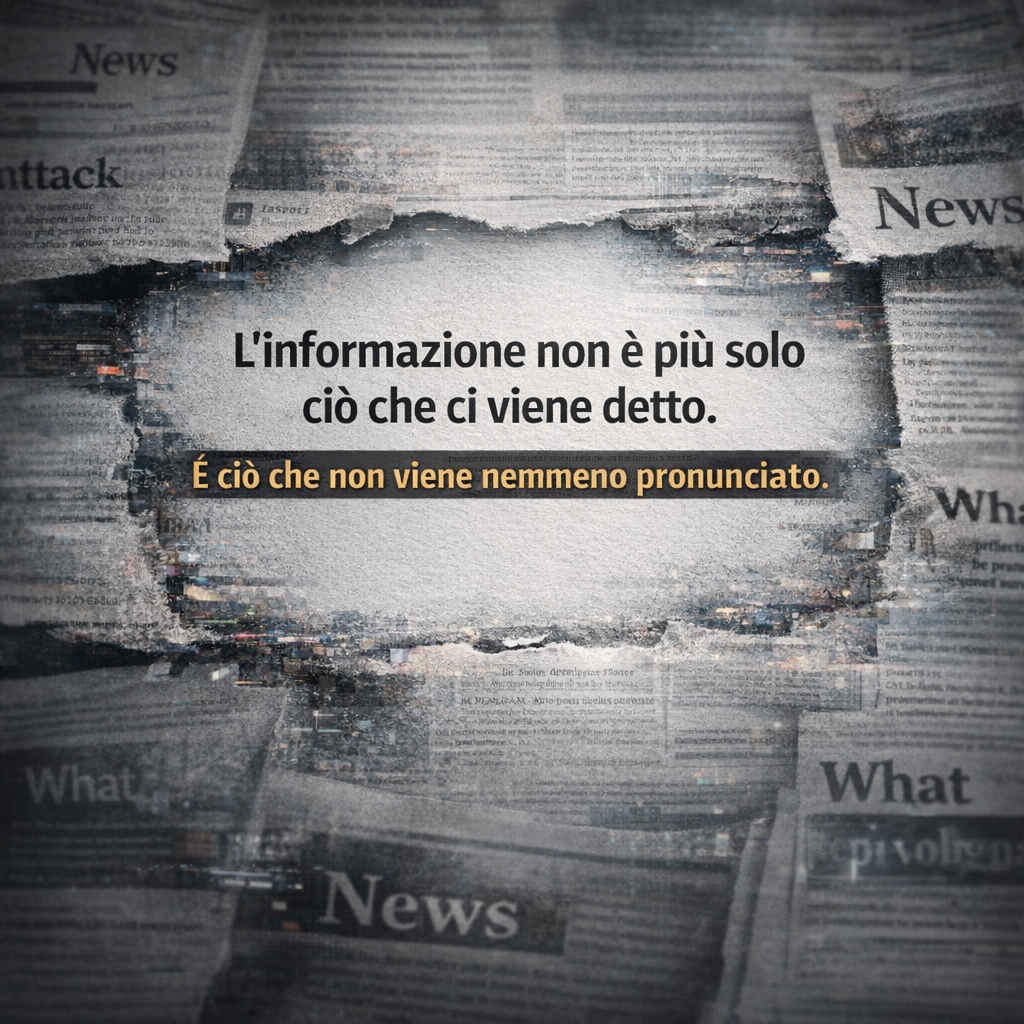
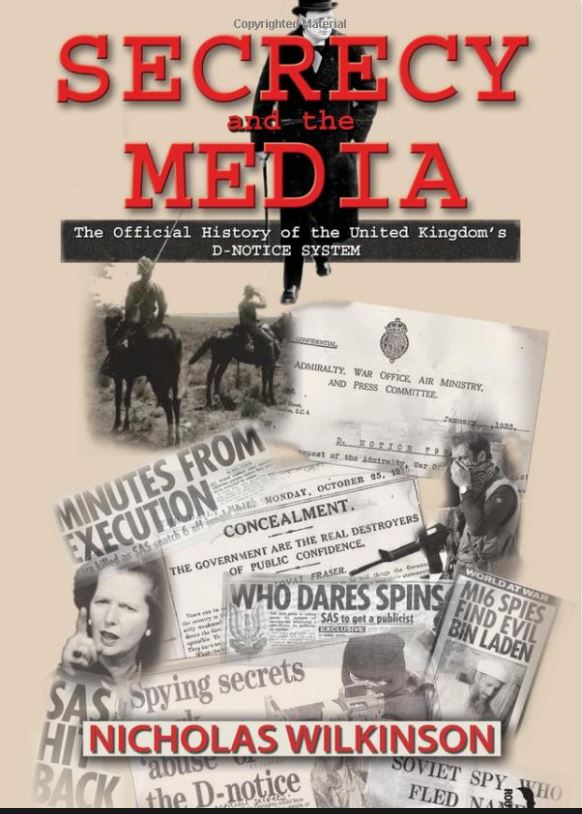
Lascia un commento