dai Cannoni di Agosto a Thirteen Days, fino a noi
Rivedere Thirteen Days oggi non è semplicemente rivedere un film sulla Guerra Fredda. È come entrare in una stanza dove, sessant’anni fa, qualcuno ha fatto una scelta controintuitiva: non vincere, ma fermarsi un attimo prima.
Il film racconta la crisi dei missili di Cuba, ma in realtà parla di qualcosa di più universale: come nascono le guerre quando nessuno vuole davvero la guerra. Non esplodono all’improvviso. Scivolano. Un passaggio alla volta. Ogni scelta sembra ragionevole, ogni risposta giustificata, ogni decisione “obbligata”. Nessuno si sente aggressore. Tutti si sentono responsabili. Ed è proprio lì che il meccanismo diventa irreversibile.
Dietro Thirteen Days c’è l’ombra lunga de I cannoni di agosto. Kennedy lo aveva letto e ne aveva tratto una lezione decisiva: nel 1914 non mancavano le intelligenze, mancavano i freni.
I sistemi funzionavano troppo bene per permettere all’umano di interromperli. Quando tutto è logico, spesso nessuno si ferma più.
Nel film il vero antagonista non è l’URSS, né Cuba. È l’automatismo. Sono i piani, le procedure, la logica dell’escalation che sussurra: “adesso devi reagire”, “adesso non puoi rallentare”. E la cosa più inquietante è che quasi tutti hanno buone ragioni. Quasi tutti sono competenti. La razionalità, da sola, non salva.
Rivederlo oggi fa ancora più impressione, perché oggi i sistemi sono più rapidi, le catene decisionali più corte, l’automazione più pervasiva. L’errore non è scomparso: accade solo più in fretta. E allora la domanda che il film ci restituisce non è storica, è attuale: siamo ancora capaci di costruire tempo dentro l’urgenza?
Thirteen Days mostra che fermarsi è possibile. Che inserire attrito, rallentare, negoziare, lasciare una via d’uscita non è debolezza, ma responsabilità. A volte la leadership non sta nello scegliere una delle opzioni sul tavolo, ma nel mettere in discussione il tavolo stesso.
Forse il vero titolo di questa storia non è “tredici giorni”.
È “un secondo prima”.
⟶ Continua a leggere
Rivedere Thirteen Days oggi non è come rivedere un film. È come rientrare in una stanza dove qualcuno, sessant’anni fa, ha scelto una cosa rarissima: non “vincere”, ma evitare di perdere tutto. E quando dico “tutto” non intendo la partita politica, intendo l’aria stessa del mondo, quella linea invisibile oltre la quale non si può più tornare indietro.
Questo film ha un potere particolare: ti fa capire che la guerra spesso non arriva con un colpo di teatro. Arriva come una serie di passi “ragionevoli” (?) , ciascuno giustificato da quello precedente.
Nessuno si sente aggressore. Tutti si sentono responsabili. E proprio lì, in quella buona coscienza diffusa, nasce l’irreparabile.
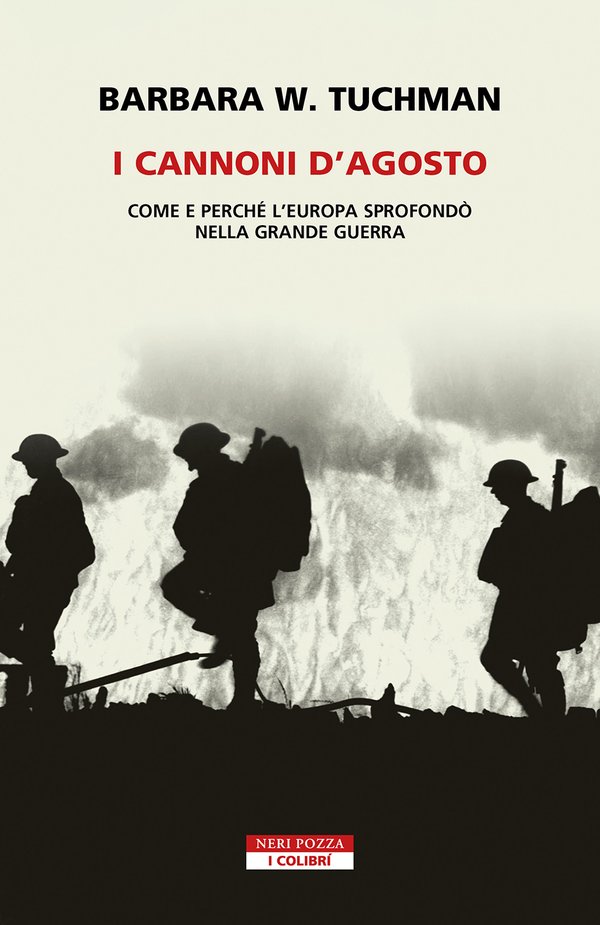
È qui che entra, come un’ombra lunga, I Cannoni di Agosto di Barbara Tuchman.
John Fitzgerald Kennedy lo aveva letto.
E in quel libro c’è una lezione che non invecchia: nel 1914 non è che mancassero intelligenze, mancavano freni.
Mancava la capacità di interrompere una catena che, una volta avviata, si autoalimenta. Tuchman non racconta una follia improvvisa: racconta un sistema che funziona troppo bene, un sistema così coerente da risultare tragico. Quando tutti credono di controllare, spesso nessuno controlla più.
Tuchman non cerca folli o “cattivi assoluti”. Racconta persone competenti, spesso animate da buone intenzioni, intrappolate però in piani rigidi, alleanze automatiche e calendari militari che diventano irreversibili. Ogni passo appare razionale. Ogni scelta sembra “obbligata”. Ed è proprio la somma di razionalità che produce il disastro: la guerra non esplode, scivola.
Kennedy lo lesse prima della crisi di Cuba e ne trasse una lezione decisiva: non basta avere ragione, bisogna saper fermare il processo. A volte la responsabilità è decidere quando non decidere subito.
Per questo Le armi di agosto non è solo storia: è un promemoria sul rischio, sull’escalation e sugli automatismi del potere. Un libro che torna attuale ogni volta che un sistema militare, tecnologico o politico diventa così efficiente da lasciare troppo poco spazio al dubbio umano.
Thirteen Days è in un certo senso il film di chi quella lezione l’ha trasformata in anticorpo. La crisi dei missili di Cuba non è solo una faccenda di URSS contro USA, o di Cuba come scacchiera. Il vero antagonista è l’automatismo, fatto passare per razionale.
Sono i piani, le procedure, la logica dell’escalation che ti sussurra: “adesso devi rispondere”, “adesso non puoi rallentare”, “adesso se non colpisci sei debole”.
Nel film non hai bisogno di un nemico demoniaco: ti basta la macchina del processo decisionale quando si mette in moto e pretende obbedienza.
E la cosa più inquietante, per uno spettatore adulto, è che la competenza non salva.
Nel film quasi tutti sono (o sembrano?) competenti.
Quasi tutti hanno buone ragioni. Quasi tutti hanno argomenti solidi.
È questo che fa paura: che il disastro possa nascere non dalla stupidità, ma da una razionalità cieca, dalla razionalità che non contempla l’umano, che non contempla l’errore, che non contempla l’effetto domino.
La guerra come effetto collaterale di un sistema che viene narrato come “ben progettato”.
Kennedy, qui, non è l’eroe muscolare. È l’eroe cognitivo, se vogliamo usare un’espressione moderna.
Non vince perché è più forte, vince perché accetta di inserire attrito.
Accetta di complicare invece di semplificare.
Accetta di allungare i tempi quando tutti urlano “adesso”.
Accetta di negoziare quando negoziare sembra quasi una resa.
Accetta, soprattutto, di lasciare una via d’uscita all’avversario, perché capisce una cosa che in politica estera è quasi una legge fisica: se umili l’altro, lo costringi a fare l’unica cosa che gli resta.
E fin qui potremmo dire: bella storia, lezione del passato, grande cinema. Ma rivederlo oggi cambia tutto, perché oggi lo guardiamo con un’ansia nuova. Nel 1962 i tempi erano stretti, certo, ma erano ancora umani. Oggi la catena decisionale, in molte aree del mondo, è più corta, più rapida, più automatizzata. Gli allarmi, le analisi, i flussi informativi corrono in sistemi che non aspettano il respiro di un uomo. La velocità non è solo un vantaggio: è una tentazione. E la tentazione è questa: scambiare la rapidità per controllo.
Qui sta il passaggio più duro dell’episodio. Non è che siamo diventati più cattivi o più stupidi: siamo diventati più veloci. E quando un sistema diventa più veloce, l’errore non sparisce, semplicemente accade più in fretta.
L’escalation non ha più bisogno di settimane.
A volte non ha neanche bisogno di ore. E allora Thirteen Days diventa una domanda rivolta al presente: siamo ancora capaci di costruire tempo dentro l’urgenza?
Siamo ancora capaci di mettere un freno quando la logica del sistema ci dice che frenare è “irrazionale”?
Ecco perché questo film, oggi, ha un valore quasi pedagogico. Non perché ci insegna “cosa è successo” nel 1962, ma perché ci mostra il gesto più raro nella storia: interrompere un meccanismo quando il meccanismo è già partito.
Tuchman ci racconta cosa accade quando nessuno interrompe.
Thirteen Days ci fa vedere che interrompere è possibile.
Il presente ci chiede se abbiamo ancora la cultura, i margini e il coraggio per farlo.
E forse la lezione finale, quella più umana, non è nemmeno geopolitica. È una lezione di leadership e di responsabilità: in certi momenti la decisione più difficile non è scegliere una delle opzioni sul tavolo. È mettere in discussione il tavolo stesso. È rallentare quando tutto spinge ad accelerare. È accettare di sembrare deboli per evitare di diventare irreversibili.
Per questo, se devo dare un titolo vero a questo episodio, non è “tredici giorni”.
È “un secondo prima”.
Perché a volte la storia si salva così: non con un gesto eroico, ma con un secondo in più di lucidità, cercando di scongiurare la Sindrome del Pollo.
Questa serie non nasce per offrire soluzioni né per distribuire colpe. Nasce per allenare uno sguardo: quello che prova a riconoscere i pattern prima che diventino destino. E nasce sotto lo sguardo del Decimo Uomo: la figura cognitiva che, quando il consenso sembra compatto e l’urgenza impone una sola direzione, si assume il compito ingrato di rallentare, dubitare, cercare l’ipotesi impopolare prima che l’inerzia diventi irreversibile. La storia, quando ritorna, raramente lo fa con le stesse forme; cambia linguaggio, strumenti, retoriche. Ma conserva le stesse fragilità cognitive: l’illusione della necessità, l’accelerazione dell’urgenza, la rimozione del limite. Lezioni dal passato è un invito a pensare quando sembra già “troppo tardi”, a ricordare che la responsabilità non coincide sempre con l’azione più visibile. A volte, il gesto più difficile – e più umano – è fermare il meccanismo mentre è ancora possibile.
Serie in corso (in ordine):
- — Lezioni dal passato – episodio 1 – Assonanze tra la fine del XIX Secolo e l’epoca contemporanea..?
- — Lezioni dal passato. episodio 2: la Pedagogia del riarmo
- — Episodio 3 – Lezioni dal passato. Lo schiaffo americano, l’ombra di Dugin e l’occasione italiana
- — Lezioni dal passato – episodio 4. Dalla fine degli imperi alla psicopolitica della NATO
- — Episodio 5 – Lezioni dal passato. Il limite rimosso
- — Tredici giorni, un agosto evitato. Lezioni dal passato – episodio 6
- — Libri, Armi e Codici. Lezioni dal passato – episodio 7
- — Arte e scienza della cucina italiana. Lezioni dal Passato – Episodio 8

Lascia un commento